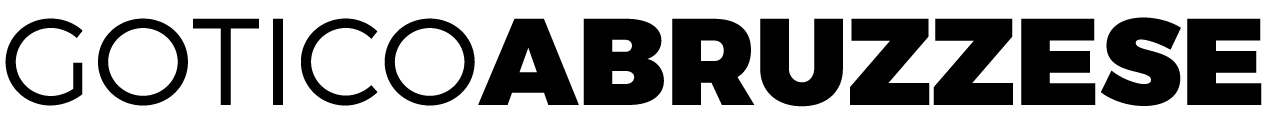Qualche anno fa mi trasferii temporaneamente a Giulianova dove avevo trovato lavoro e dove condividevo una graziosa villetta in riva al mare con un amico male in arnese quanto me. Al mattino mi piaceva fare colazione in un bar sul lungomare, un bar di cui non ricordo il nome, ma che già dall’apertura diveniva ritrovo di pescatori locali di ogni età, che vi si radunavano dopo le primissime battute di pesca a ridosso dell’alba.
Mi piaceva un sacco starli ad ascoltare mentre, appoggiato al bancone, consumavo il mio cappuccino con cornetto. Molti di loro, i più anziani perlopiù, parlavano giuliese stretto, una lingua all’epoca per me incomprensibile, e proprio come in un libro di Melville erano soliti raccontarsi vecchie storie di pesca vantandosi a vicenda dei propri successi e trofei.

L’ e lu mare, regia di Claudio Romano | © Comune di Tortoreto
Tra loro ve n’era uno che sembrava il più anziano di tutti, seduto sempre da solo e sempre allo stesso spartano tavolo di resina bianco, con una Peroni da 33cl costantemente a metà dinnanzi. Sembrava ascoltare tutti svogliatamente, forse annoiato dalla riproporsi costante di quelle chiacchiere che ormai aveva imparato a memoria. Aveva una bella barba bianca, di quelle che la natura regala solo ai saggi, e non lo avevo mai sentito proferire parola alcuna, nonostante le chiacchiere in quel bar non mancassero.
Un giorno, mentre ero impegnato in una delle mie solite colazioni, assistevo insieme agli altri ad un’accesa discussione tra alcuni giovani clienti del locale, che dibattevano la notizia in prima pagina sul quotidiano del giorno: due esperti scalatori morti il giorno precedente durante una ferrata su una parete del Corno Grande del Gran Sasso. La diatriba era particolarmente sentita, e si divideva tra chi cercava di giustificare l’accaduto come semplice sfortuna e chi invece accusava le vittime di aver sottovalutato ingenuamente la pericolosità di una scalata del genere.
Il vecchio pescatore con la barba, seduto al suo solito tavolo, leggeva interessato la notizia senza comunque partecipare. Uno dei giovani pescatori impegnati a dibattere, nel vederlo così concentrato, gli chiese cosa ne pensasse e in un attimo tutto nel bar sembrò come fermarsi. Gli avventori apparivano interessati alla sua opinione e io stesso abbandonai per un attimo la mia colazione voltandomi per osservare meglio il momento in cui, finalmente, il vecchio pescatore avrebbe parlato.
“Sfidare la montagna, così come il mare, non è da furbi né da ingenui. E’ da uomini, e gli uomini a volte vincono, e altre volte perdono.”
Nessuno nel locale si sentì in dovere di aggiungere altro.
* * *
Betty mi dice che molte zone del teramano sono irraggiungibili a causa della neve. Telefono ed elettricità sono interrotte, le turbine inviate per aprire le strade non sono idonee a scavare la mole di neve piovuta dal cielo. A Valle Castellana le precarie strutture ancora in piedi stanno crollando, c’è un’alta probabilità di non trovare più il paese quando a primavera la neve sarà disciolta, come nell’epilogo di un trucco attuato da un prestigiatore di bassa lega, realizzato in maniera gretta e con la soluzione dell’inganno ben visibile a tutti.

Valle Piola (TE) © Chiara D’Amato
Dico a Betty che quello di scomparire è parte di un destino che realtà come queste mettono in conto da sempre, ed è per questo che luoghi del genere esercitano su di noi un certo fascino. Perché a differenza di una metropoli, un paese può scomparire, rinascere, riscattarsi o morire, e questo li rende più umani, più simili a noi.
“L’Abruzzo” – mi dice – “ferocemente seleziona gli abruzzesi“.
“E i suoi paesi” – le rispondo – “E’ così da sempre“.
* * *
Il 13 Gennaio di 102 anni fa il terremoto della Marsica distrusse quasi completamente gli insediamenti della Valle del Fucino. A causa del sisma morirono circa trentamila persone.
Faceva freddo, e la neve caduta, le frane e le macerie ostacolarono per giorni le operazioni di soccorso. I superstiti vennero organizzati in baraccopoli di fortuna realizzati con legname di recupero, molti degli uomini dei paesi e dei comparti degli aiuti vennero presto richiamati al fronte perché in quegli stessi anni imperversava la guerra.

Terremoto della Marsica, 102 anni fa.
Il disastro fu ben raccontato dalla penna di Ignazio Silone, figlio illustre del piccolo borgo di Pescina, alle porte dell’antica Valle del Giovenco, attraverso cui le prime popolazioni umbre e sannite occuparono questo territorio dando vita al ramo autoctono dei marsi.
Nel suo Uscita di Sicurezza, lo scrittore mette a disposizione del lettore i suoi ricordi di sfollato e di orfano (Silone perse entrambi i genitori nel disastro), insieme alla cronistoria di quella che fu poi la sua formazione quale militante del Partito Comunista.
Mi è capitato di trovare questo libro qualche giorno fa in un mercatino e di acquistarlo con l’idea di inviarlo ad un amico, vorace lettore al momento costretto ad una vacanza forzata a spese dello Stato. Ho iniziato a leggerlo per curiosità, la sera, prima di coricarmi, e alla luce di quanto accaduto in questi giorni l’ho considerato un po’ un presagio, un messaggio in bottiglia perso nel mare del tempo, e ritrovato fortuitamente da un abruzzese qualunque proprio nel momento in cui ne aveva più bisogno.
Lo invierò comunque al mio amico di penna, ma prima finirò di leggerlo.
* * *
La prima scossa con epicentro a Montereale è appena finita, ma il clamore mediatico ha già iniziato a ronzare. Nei bar, nelle case, nei discorsi, nei post sui social network: la gente ripete la nuova nenia come un mantra, un modo come un altro per esorcizzare la paura.
Il maltempo degli ultimi giorni ha causato un black out energetico nella zona in cui vivo, con conseguente congelamento della rete idrica domestica a causa dello spegnimento della caldaia. Non ho luce né acqua, e a causa del ghiaccio per strada ho anche sbattuto con la macchina. Chiedo asilo ai miei e una volta giunto scopro che mia sorella ha fatto altrettanto, portandosi dietro il suo compagno e la loro bambina di un anno e mezzo. Vivono in una vecchia casa del centro storico e ora hanno paura di restarci a causa delle nuove scosse. Trascorrono il pomeriggio a guardare gli aggiornamenti in TV, dove i titoli in sovrimpressione scorrono sulle parole di geologi, metereologi ed opinionisti vari che continuano a parlare senza sosta, molti senza neanche averne diritto.
Sono stanco, non sopporto tutto quel vociare a vuoto, le frasi fatte del palinsesto del pomeriggio, le facce di presentatori e giornalisti in diretta dai luoghi caldi dell’emergenza.
Fuori nevica ancora. Una neve infame, pesante e viscosa, che appesantisce i tetti dei pollai e spezza rami e recinti. Con alcuni amici decidiamo comunque di uscire a fare due passi. Viviamo tutti in periferia, ci dirigiamo a piedi in un piccolo paesino alle falde del Genzana, a un’oretta di cammino dalla nostra contrada.

Quelli di Valle Yuva.
La strada è deserta, magnifica e silenziosa. Spengo la connessione dati del telefono, per un attimo mi sembra di uscire dal mondo. La neve che isola e spaventa diventa allora un rifugio, un’oasi di pace che sembra proteggerci dall’isteria, mentre a pochi passi dal bar del paese i giovani del luogo sono impegnati nei soliti discorsi.
Ci guardano male quando, saputo della nostra piccola traversata, si offrono di accompagnarci a casa a bordo di una delle loro jeep da montagna, ma rifiutiamo con un sorriso.
“Preferiamo camminare” – rispondiamo all’unisono, e poi ci avviamo a ritroso verso valle.
* * *
Molti amici che vivono fuori mi scrivono.
“Come va lì da te? Tutto apposto?”
Mi fa piacere la loro premura, la loro vicinanza in un momento difficile. E’ sempre bello sapere di non essere soli.
Minimizzo, rispondendo che si, va tutto bene, c’è chi sta peggio di noi e purtroppo possiamo fare poco per aiutarli.
Nel cuore però sento come un’interferenza, un segnale di disturbo. Questo però non lo dico.
Mi tornano alla mente quei giorni d’Aprile del 2009, quando finalmente capimmo, oppure ricordammo, cosa vuol dire essere abruzzesi.

L’Italia che trema.
Del terremoto a L’Aquila ricordo tanta polvere, gli edifici che sembravano bombardati e le impronte di sangue per strada di chi era scappato di casa a piedi nudi. Ricordo la voce di mia sorella, quando alle 11:00 del mattino del 6 Aprile, riuscii finalmente a mettermi in contatto con lei e a dirle che stavo bene, e gli abbracci con amici e conoscenti che capitava di incontrare per strada, prima che ognuno riprendesse a girare in ogni dove come una trottola impazzita.
Ricordo una folla di persone in apprensione davanti le macerie della casa dello studente, dove ragazzi in lacrime e genitori alla continua ricerca di informazioni aspettavano con ansia una risposta dai soccorritori.
Un’amica mi chiede se quella notte avessi avuto paura. Le rispondo che no, mi sembrava solo tutto assurdo, non capivo bene cose stesse accadendo.
Di paura ne ho avuta dopo, quando ho iniziato a capire cosa significa “ricostruzione” per la gente normale, un processo abominevole e schifosamente lucrativo per chi non è interessato alle sorti e alla cultura delle vittime.
Allo stesso modo però ho imparato col tempo ad acquisire nuove e più piacevoli consapevolezze, come il ritenermi fortunato per essere scampato a qualcosa che ha invece ucciso altri come me, o nel constatare un nuovo e rinnovato senso di appartenenza da parte di un nutrito gruppo di cittadini, promotori, tra le altre cose, dell’apertura di nuovi spazi sociali e culturali in città.
Ci voleva un terremoto per scuotere la mia ed altre coscienze a reagire? Non so dirlo, ma è così che l’abbiamo imparato.
* * *
La nostra è una regione difficile. Da sempre. Chi ha scelto di viverci dovrebbe farci pace, o perlomeno saperlo.
Di lavoro non ce n’è mai stato molto e per anni il nostro miglior prodotto da esportare sono state le nostre genti. La ciclicità di eventi come quelli dei giorni scorsi dovrebbe far riflettere, cosa che puntualmente evitiamo di fare salvo poi ritrovarci disorientati quando tornano a verificarsi.

Contadino di Bisenti (TE) © Gianni Ambrosio, 1976
Sono abbastanza certo che, checché se ne dica, fosse così anche per i nostri avi, ma con due differenze, forse sostanziali.
La prima è che non avevano modo di mostrare al mondo i propri morti e le proprie disavventure, senza gli affacci che l’informazione mediatica concede invece a noi oggi (con tutto ciò che di positivo e negativo ne consegue).
La seconda è invece rappresentata da un approccio più cosciente al territorio che li circondava e alla natura parte di esso. La moderne capacità tecnologiche in nostro possesso hanno contribuito col tempo a far si che queste consapevolezze scemassero, dimenticando parte di quell’immenso sapere che chi ci ha preceduto aveva invece acquisito con grande sacrificio e remissione. Abbiamo imparato a sottovalutare la natura, i suoi ritmi, le sue insidie, provati forse da un senso di riscatto nei confronti di una forza che per secoli aveva così pesante influito sulla nostra quotidianità.
Ma vive in noi, come abruzzesi e più in generale come “genti di confine”, per citare Ennio Flaiano, un’araba fenice destinata a risorgere dai propri lutti, dalle proprie pene, dalle proprie macerie, perché è parte di noi la tempra di chi è abituato al vento impetuoso della vita. E’ parte di noi il tremore della terra e la neve gelida e copiosa, la dura roccia e i capricci del mare. Sono parte di noi i nostri umani paesi, e la cruda fierezza degli animali delle nostre montagne. Sarà forse nostra un giorno anche la barba di quel pescatore giuliese, bianca di neve e mossa solo dalle sagge parole che allora sapremo pronunciare.
Nel frattempo ci prepariamo alla notte, in attesa della prossima primavera.