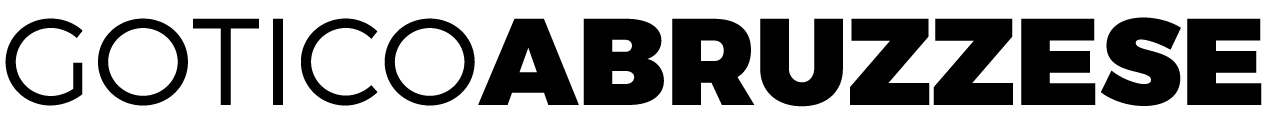Di Antonio Secondo. Foto di Antonella Palombizio, Antonio Secondo e Paolo Giovanni D’Amato.
In capo a tutti c’è Dio, padrone del cielo.
Poi viene il principe di Torlonia, padrone della terra.
Poi vengono le guardie del principe.
Poi i cani delle guardie del principe.
Poi, nulla.
Poi, ancora nulla.
Poi, ancora nulla.
Poi vengono i cafoni. E si può dire ch’è finito .
Ignazio Silone, Fontamara – 1933
Nel 1980 fu realizzato uno sceneggiato RAI diretto da Carlo Lizzani in cui sono ripercorse le vicende di Fontamara, il più conosciuto romanzo dello scrittore marsicano Ignazio Silone. L’opera vede l’interpretazione di un giovane Michele Placido nei panni del tumultuoso Berardo Viola (a dire il vero molto meno tumultuoso e politicizzato di come ce lo ricordavamo nel libro).

Michele Placido nello sceneggiato RAI “Fontamara”, 1980
Scritto da Lucio de Caro, lo sceneggiato è un prodotto decisamente migliore rispetto ai moderni pseudopolpettoni riscaldati di mamma RAI che tutta la mia generazione ha imparato ad odiare con passione, e raggiunge a mio avviso il suo apice in una scena che ad una prima visione sembra passare inosservata. Nei primi minuti si vede infatti Berardo ridiscendere un brullo tratto di montagna trascinando dietro di sé una scalcinata slitta piena di legna da ardere. A Fontamara fa freddo e di legna ce n’è bisogno in abbondanza. Una volta fuori dalla porta di casa, Berardo si ferma a riprendere fiato, stanco e sudato dopo la lunga fatica. Giovanni, suo concittadino, gli fa notare che continuando con quella vita finirà per morire di fatica.
“O io ammazzo la montagna, o la montagna ammazza a me” – risponde lui, gridando.
Una frase del genere ti colpisce perché non ha niente della sacralità con cui Messner o altri grandi scalatori descrivono il rapporto con le catene montuose. Una frase del genere racchiude in sé il senso di una razza, quella degli abruzzesi cresciuti all’ombra del Morrone, del Gran Sasso e di lei, la madre di tutte le montagne d’Abruzzo, la Majella.

Monte Amaro, comprensorio della Majella. © Paolo Giovanni D’Amato
Racconta la leggenda che la sua vetta, il Monte Amaro, sia nato con morte della dea Maia, fuggita dalla Frigia per scampare alle oscenità di una guerra che aveva mortalmente ferito suo figlio Ermete. Così, inseguita dal nemico e con in braccio il fanciullo morente, Maia riuscì con una zattera di fortuna a raggiungere le coste adriatiche, sbarcando nell’attuale Ortona.
Dopo un breve cammino dovette suo malgrado constatare la morte del figlio. Lo depose così a terra, ricoprendolo di sassi e dando vita alla vetta del Corno Grande del Gran Sasso (che, vista da una certa prospettiva, sembra difatti un volto con gli occhi chiusi). Stremata dal dolore, Maia continuò il suo pellegrinaggio fino ad accasciarsi esausta e morire. Il suo dolore per la perdita del figlio, grande quanto una montagna, diede vita a quell’amaro macigno, il cui passo più famoso è ancora oggi conosciuto come “Passo di femmina morta”.

Panorama dal comprensorio del Sirente. Foto di Antonella Palombizio
Spirituali, impervie, magiche; le montagne abruzzesi vivono da sempre un continuo rapporto di amore–odio con gli abitanti degli isolati villaggi su di esse arroccati. Popolate di miti contadini che le vogliono ora abitate da orchi, ora da fate, questi monumenti al temperamento abruzzese rappresentano perfettamente l’effigie di “forti e gentili” donata al nostro popolo dallo scrittore Primo Levi. I suoi paesaggi riflettono da un lato l’immaginario da cartolina di rigogliosi pascoli primaverili, attraversati da numerosi greggi di pecore e dai loro governanti umani e canidi, dall’altro gli spettrali e maestosi panorami di una natura cruda, selvaggia, indomabile, che con la sua forza ha per anni costretto chi vi abitava a sottostare alle sue leggi.

La linea di confine tra il territorio marsicano e quello subequano sulla piana di Baullo, comprensorio del Sirente – Velino. Foto di Antonella Palombizio
In molti di questi luoghi il tempo sembra essersi fermato, quasi neanche la modernità di computer e smartphone, nonostante il suo continuo avanzare, sia ancora riuscita a domarli. Come qui, a Baullo, altopiano del Velino – Sirente e terra di confine tra la Marsica e la Valle Subequana, dove a farla da padrone sono ancora maestosi monoliti, animali allo stato brado e fitta vegetazione.
È strano oggi ritrovarsi in un luogo così vicino alla civiltà, eppure così isolato, dove le leggi della natura hanno ancora un ruolo quasi totalmente determinante su ciò che accade. Ci si sente spaesati, rapiti, totalmente coscienti di quanto non siamo nulla senza GPS satellitari, Ipad e navigatori di ultima generazione. Eppure se oggi la modernità con i suoi potenti mezzi non ha ancora espugnato queste lande alla natura, fino a ieri schiere di uomini disperati ed insaziabili sono riusciti, senza sofisticati strumenti ma solo con grande forza d’animo, a conquistarsi questo antico feudo dei Piccolomini per riuscire a sopravvivere.
Senza andare troppo indietro negli anni, fino al secondo dopoguerra, questa zona era difatti un importante granaio per le popolazioni locali. Veniva coltivato su questi altopiani il grano di Solina, varietà autoctona che per anni ha donato sostentamento alle tante famiglie del luogo, non senza difficoltà. Immaginare cosa abbia significato in quegli anni lavorare in campi a 1100 metri sul livello del mare è qualcosa di impossibile per chiunque, tranne per chi lo ha vissuto sulla propria pelle. Basti pensare che il comune più vicino, quello di Gagliano Aterno, sorge a una ventina di minuti di macchina da queste terre, e che per raggiungerlo a piedi sono forse necessarie dalle due alle tre ore. Una volta su, dopo l’immane sfacchinata in salita, toccava iniziare a lavorare sotto il sole di Luglio, che in montagna, si sa, picchia di più.

Non è raro, durante una scampagnata in montagna, imbattersi in questi cumuli di pietre. Accatastate dai contadini che una volta lavoravano queste terre, questa operazione, compiuta a mano, era necessaria sia per far spazio alle colture sia per delimitare le proprietà agricole. Foto di Antonella Palombizio
Mentre sono qui quasi me li vedo quei contadini stanchi mentre, arnesi in mano, picchiano contro questa terra maledetta, da cui dipende la loro sopravvivenza, tenendo testa al dolore necessario per lavorarla.
“ ‘ste montagne sono un carcere, e Fontamara è un ergastolo” – dice ancora il personaggio di Berardo Viola nel libro di Silone.
Già, perché nonostante l’immaginario comune vuol dipingere quasi sempre queste genti come spensierati e gioiosi agricoltori che cantano nei campi, in un universo quasi hippie fatto di buon cibo e aria fresca, la verità è che qui si gettava il sangue, e con lo stesso si irrigavano le terre. Ci si abbrutiva, si invecchiava, ci si irrigidiva, divenendo a propria volta parte del paesaggio, come una di quelle rocce secolari che ancora sono qui, immobili, ad ascoltare il vento.

La Madonna del Carmine di Baullo nella sua edicola votiva. Foto di Antonella Palombizio
Spaventati dalla natura che li circondava i contadini inventavano storie, come quella del Vallone dell’Inferno, che apre la strada verso l’altopiano descritto in precedenza.
Qui le dicerie raccontano che dimori un demone, nascosto nel cuore di un profondo e scosceso crepaccio. La leggenda parla di un cavaliere che mentre attraversava questa pianura udì il pianto di un bambino provenire da un cumulo di rocce poco lontano.
Scoperto l’infante, il cavaliere lo issò sopra la testa per osservarlo meglio, cadendo così vittima di un incantesimo. Al bambino spuntarono corna e una lunga coda draconica e con occhi di fuoco ipnotizzò la sua vittima che tentava invano di gettarlo via. Il militare, quasi sopraffatto dalla forza demoniaca del bambino, invocò l’aiuto della Madonna del Carmine, che prontamente giunse, scaraventando il demone lontano. Nel punto dove cadde la terra si squarciò, formando il Vallone.
Per questo i contadini posero in un’edicola votiva la statua di una Madonna che tutt’ora vigila affinché il demonio non risalga le pareti del crepaccio in cui è stato imprigionato. Ancora oggi, a Luglio, i cittadini di Gagliano Aterno ripercorrono in processione la lunga strada che porta a Baullo, fino ad arrivare all’edicola per rendere grazie.

Il Vallone dell’Inferno. Foto di Antonio Secondo
Oggi Baullo vive nei ricordi di chi in passato ha partecipato alla sua conquista, una generazione che sta lentamente scomparendo e che porterà con se tutte le storie, le leggende, le memorie di quegli anni. Ossa di animali predati spuntano da ogni dove, testimoniando che la lotta per la sopravvivenza è oggi solo affare della natura che vi abita.
Ciò che rimane sono i dettagli attraverso i quali immaginare una realtà che fu: rifugi, sinistre guglie di roccia immerse nel niente e quel vento incessante che sembra parlare una lingua millenaria, ancestrale, fuori dal mondo, mentre sale dal Vallone dell’Inferno e ti investe con tutta la sua forza, quasi fosse un demone che volesse possederti.
- All’esterno di un rifugio sull’altopiano di Baullo
- Edicola votiva della Madonna del Carmine
- Monoliti
- Passeggiando per Baullo
- All’esterno di un rifugio sull’altopiano di Baullo
- Santa Tibia, rifugio Baullo
- Nel bosco
- All’esterno di un rifugio sull’altopiano di Baullo
- All’interno del rifugio di Baullo
- Tracce